Fuori rete
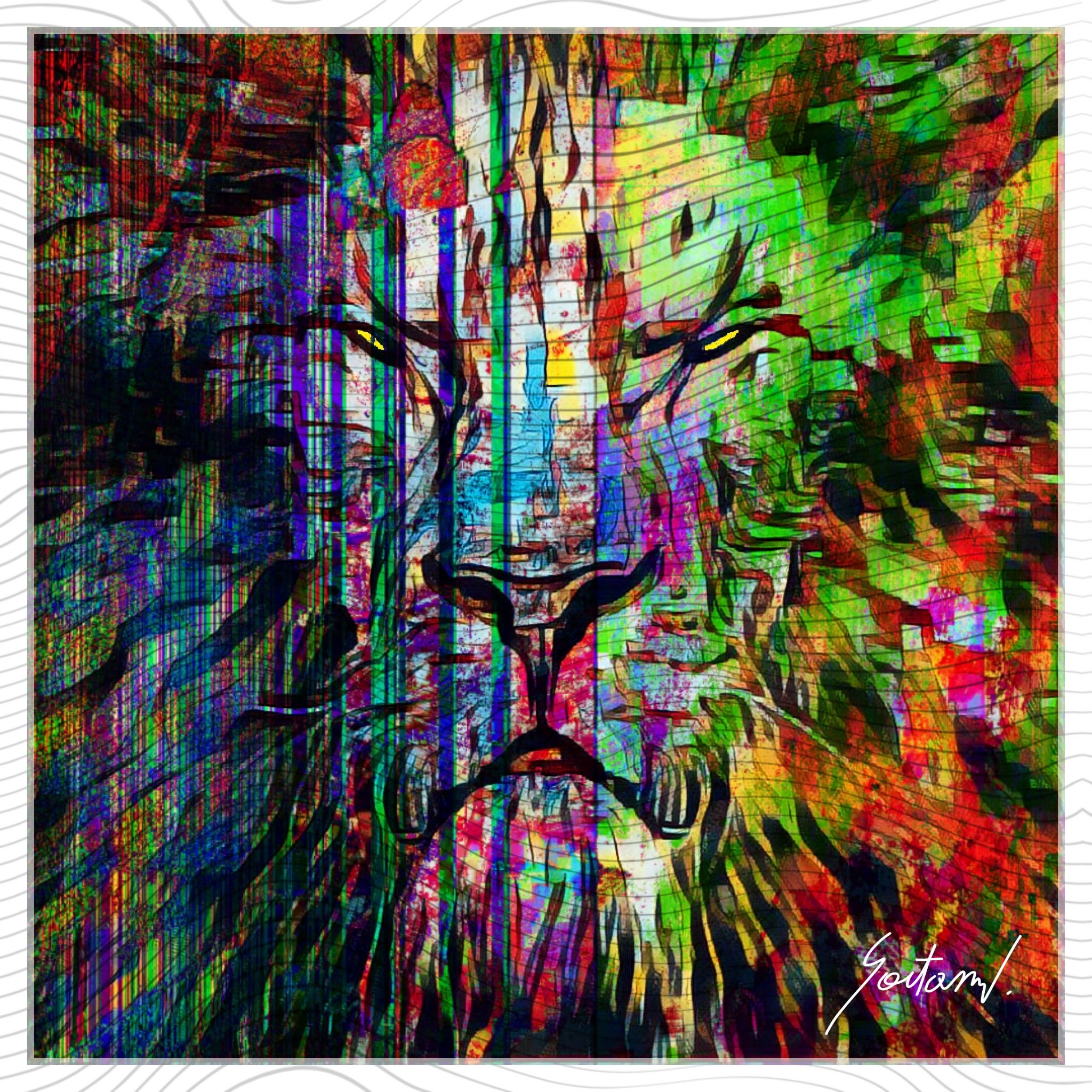
Dove torno a rimbalzare disordinatamente da Facebook al blog e viceversa
Tanti amici hanno già deciso o stanno decidendo in questi giorni di mettere i piedi fuori dal meta-flusso di Facebook, per non lasciarsi contagiare dalle sue acque torbide, per non farsi trascinare dalla corrente e per fare in modo che i loro dati e le loro emozioni non siano sfruttati per fini commerciali. Altri, semplicemente, riducono progressivamente la loro esposizione ai social cercando di liberarsi in modo morbido dall’assuefazione.
Io, invece, per il momento, ci resto ancora del tutto invischiato. Forse perché mi illudo di navigare a pelo d’acqua e di governare la rotta a mio piacimento. Sento, in qualche modo, di essermi mitridizzato. E poi, mi ripeto fino all’autoconvincimento che osservare il fenomeno dall’interno serve a farmi capire meglio le nuove generazioni e la deriva che sta prendendo la mia.
Eppure, tante volte, vedendomi dal di fuori, mi sento come un tossico che mentre assume la sua dose ripete a se stesso e al mondo io-smetto-quando-voglio.
E allora, vado dicendo in giro che restare in questo magma liquido mi serve pure per confrontarmi con amici, conoscenti e sconosciuti vicini e lontani; anche se constato ogni giorno che ci vuole molta pazienza per dibattere in uno spazio polarizzato, aggressivo, viscerale e umorale come il Faccialibro. Tanto più quando si intraprende una discussione in un gruppo pubblico o privato, dove, nella moltitudine, ognuno sembra perdere il suo senso del limite, il rispetto per l’altro e il valore della propria responsabilità personale. Un po’ come accade nei fenomeni di violenza collettiva (guerre, genocidi, lotte tra bande rivali, stupri di gruppo, tifoserie da stadio, atti di bullismo e di teppismo perpetrati da una massa di persone più o meno indistinta), dove, dal gregge, vengono fuori i ruggiti dei leoni da tastiera che si sentono protetti dalla distanza, dalla complicità della propria bolla di amici virtuali e, talvolta, anche dal loro relativo anonimato.
Alla luce di questa somma indistinta di ragioni e sensazioni, ritengo e ripeto spesso che era molto meglio quando si navigava nella “blogosfera“, quando, cioè, si interagiva, ognuno dal proprio blog personale, con un gruppo di persone che, di solito, era molto più limitato e circoscritto di quello degli attuali social. Mi pare che tra i blogger ci si leggesse reciprocamente con più attenzione, che i commenti fossero più ragionati, che le comunità fossero più salde. E poi si era più padroni dei propri post e perfino dell’impaginazione e della grafica dei testi pubblicati. (Sarà per questo che mi ostino a tenere vivo il mio vecchio blog in parallelo con i miei spazi feisbukkini e tante volte il Faccialibro lo uso anche come un trampolino per far rimbalzare i miei venticinque più affezionati lettori dal social ad aitanblog.wordpress.com).
Insomma, diciamo che resto nel Faccialibro per vedere l’effetto che fa, ma anche per alimentare il mio personale narcisismo e, proprio per questo, mi spiace quando alcuni dei miei amici decidono di andare via e finiscono per lasciarmi più solo tra la folla sterminata del meta-coso.
Questo, naturalmente, non vuol dire che non capisca e non rispetti fino in fondo la scelta di chi lascia, né che non senta anch’io l’esigenza di tenermi per qualche tempo lontano da questa sovrabbondante autorappresentazione pubblica (l’io che parla a un voi) per tornare a praticare con maggiore intensità una comunicazione a tu per tu.
Non a caso, un giorno sì e l’altro pure avverto l’esigenza di disconnettermi per far sì che il tempo pubblico che passo su FB non eroda il mio spazio privato. Disconnettermi per riconnettermi con me stesso e con il mondo reale, insomma.
Anche perché temo che, sotto sotto, continuiamo a restare invischiati nei social perché ci risulta molto più facile e meno impegnativo fare dichiarazioni sulla pace universale in rete che prenderci cura di chi ci sta vicino (il prossimo), e più facile anche comunicare a una massa indeterminata di persone che chiamare un amico in difficoltà o parlare con chi si sente solo o abbattuto. Ma, soprattutto, so bene che per tutti noi è meno faticoso e più comodo fare parte di una comunità virtuale che fare comunità (e agire) nel territorio in cui viviamo.
Qualche tempo fa scrivevo in un altro contesto che “per noi boomers il mondo sembra essere tutto dispiegato sul Faccialibro e difficilmente siamo indotti ad affacciarci su quello che succede fuori dalla sua rete protettiva. Se ci debbono dire qualcosa, che lo dicano sul muro sicuro di quella bacheca. Anche perché fuori da quel microcosmo, considerato che non troveremo i nostri pollicioni, i cuoricini, gli abbracci e le faccine, non riusciremmo più ad esprimere un nostro giudizio, una nostra emozione o un pensiero personale.”
Insomma, la nostra bolla di “amici” di Facebook è diventata la nostra “comfort zone” e, il più delle volte, abbiamo poca o nessuna intenzione di uscirne. Sarà per questo che tendiamo a riversare in rete gioie, tragedie e dolori, che finiscono per diventare (in modo più o meno in/consapevole) dei meccanismi acchiappalike.
Perché, è inutile negarlo, se si scrive qua sopra, si cerca il consenso (o almeno la reazione) dell’altro; per quanto si tratti di un altro indistinto, moltiplicato per il numero degli “amici” che si hanno in bacheca. E il fatto stesso di scrivere a un voi indistinto e mobile fa adeguare il tono e lo stile della nostra comunicazione alla molteplicità degli interlocutori, rischiando anche un appiattimento di forma e contenuti. (Di questo io credo di essere abbastanza consapevole da selezionare in modo quasi automatico quello che voglio scrivere sul blog, quello che destino alla mia bacheca pubblica, quello che metto nella pagina dei vicini di aitan e quello che destino a gruppi di carattere più “politico” o, al contrario, a singoli amici ai quali sono legato da un rapporto di comunicazione più intima e personale. Magari anche fuori dalla rete, nel mondo extra-virtuale.)
Tuttavia, poi mi dico che, alla fine dei conti, anche uno scrittore di libri di carta (come un utente dei social) scrive ad un voi indistinto. Nessuno mette fuori le sue parole in forma scritta solo per rileggersele da solo (anche perché perfino l’io che rilegge i suoi propri testi, a distanza di tempo, risulterà sempre diverso dall’io del momento in cui li stava scrivendo). Umberto Eco sosteneva che “c’è una sola cosa che si scrive solo per se stesso, ed è la lista della spesa. Serve a ricordarti che cosa devi comperare, e quando hai comperato puoi distruggerla perché non serve a nessun altro. Ogni altra cosa che scrivi, la scrivi per dire qualcosa a qualcuno”.
Il problema, certo, è che quel qualcuno, in un social network, per quanto indistinto, può essere più condizionante del pubblico dei lettori di carta. Perché in Facebook, anche se hai 5mila amici, ogni potenziale lettore ha un nome e un cognome (per vero o fittizio che sia). E, se fai il medico e parli di ospedali, finisci inevitabilmente per pensare che ti leggeranno anche gli infermieri, i pazienti, i colleghi e il primario. E poi quel qualcuno che ti legge sulla “tua” pagina Facebook ha diritto di parola su quello che scrivi e può interagire con te. E spesso lo fa (lo farà) in modo spiacevole, aggressivo o adulatorio.
Il mezzo, insomma, non è innocente. Nelle sue dinamiche chiunque entri resta invischiato (irretito), anche se con differenti gradi di consapevolezza, di disumanizzazione e di dipendenza. Fino alla perdita di controllo sulla propria vita e all’isolamento come deriva esistenziale.
Il rischio della disumanizzazione (e anche quello dell’alienazione) diventa ancora più forte nelle nuove generazioni. Noi boomers conosciamo la comunicazione dello spazio e del tempo extravirtuale; sappiamo che esiste anche una comunicazione a tu per tu non amplificata e deformata dalla rete. Il rischio è che le nuove generazioni conoscano solo questa modalità comunicativa io a voi e che non sappiano più cosa voglia dire avere una propria privacy, o sussurrarsi parole all’orecchio.
Sì è creato, insomma, un terribile circolo vizioso: ci isoliamo dal mondo, viviamo collettivamente come degli arcipelaghi legati dal mare che ci separa, e poi, navigando in quelle stesse acque, cerchiamo continue conferme che gli altri abbiano letto (e gradito) i messaggi che abbiamo lanciato senza mettere un preciso destinatario sulle nostre bottiglie da naufraghi. E quando non ci leggono (o non gradiscono) cresce in noi la frustrazione e lo sconforto.
Ma, beninteso, questo non è solo un problema dei millenials, di quelli della generazione Z o dei nativi digitali.
È brevissimo il passaggio dall’hikikomori adolescente che si chiude in una stanza di fronte a uno schermo al kodokushi (la morte solitaria) del cinquantenne ritrovato cadavere putrescente in una casa trasandata in cui si accumulano rifiuti tristezza e solitudine.
La mancanza di parole per dire agli altri il proprio disagio, lo sfaldamento di ogni relazione con un’altra singola persona a favore di una pseudocomunicazione con un gruppo indistinto di altri che più che interlocutori diventano “pubblico”, la rappresentazione falsata di se stessi attraverso lati buoni, labbra a culo di gallina, fotoritocchi e avatar non fanno che aumentare la nostra solitudine, fingendo di colmarla.
Un processo di disumanizzazione e alienazione che rischia di aumentare l’insoddisfazione e renderci peggiori. Soprattutto quando è più forte la distanza tra la nostra vita virtuale (iperattiva) e la nostra vita extra-virtuale (passiva, spenta o inesistente).
Forse il segreto consiste nel presentarsi per quello che si è ed usare un linguaggio simile sia quando si è dentro che quando si è fuori dalla rete. Senza fotoritocchi, abbellimenti, trucchi, citazioni prive di fonte, appropriazioni indebite, risate stampate sulla faccia e ricerca spasmodica del lato buono. Essere autentici. Presentarsi per quello che si è, con i propri difetti, le proprie mancanze, i propri pregi e le proprie contraddizioni. Rispettare gli altri, non alzare la voce e rispettarsi. Essere gentili. Mettersi in ascolto. Togliersi la maschera e restare umani! Anche quando si scrive e ci si rappresenta da dietro uno schermo protettivo, al riparo della rete.
Aitan (https://aitanblog.wordpress.com) #Divita #Diconnessione
Home – Identità Digitale Sono su: Mastodon.uno - Pixelfed - Feddit