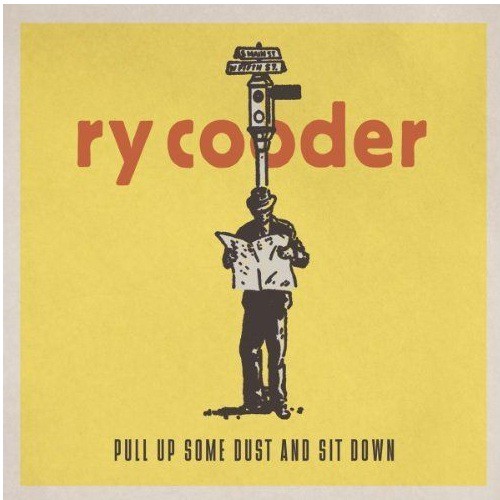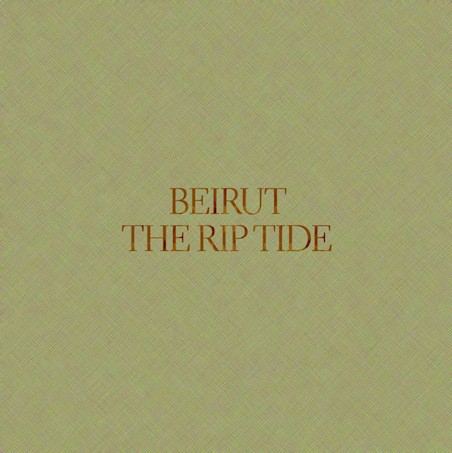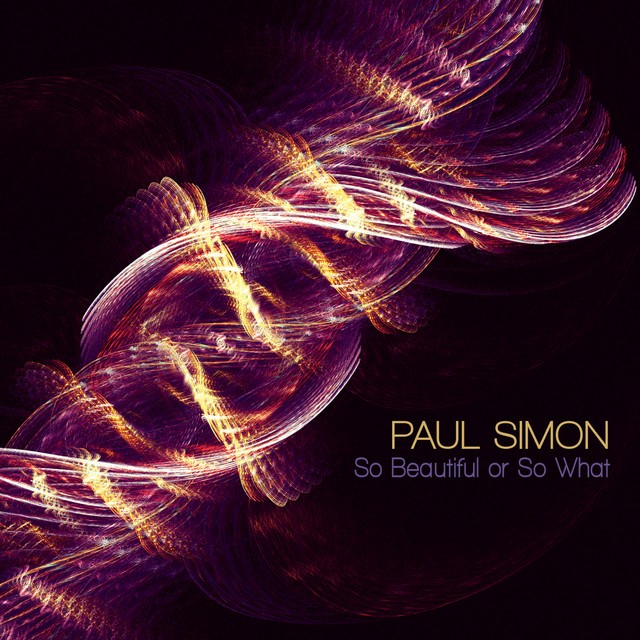Tom Waits — Bad as Me (2011)

Recensire un disco di Tom Waits non è impresa facile. Il suo essere fuori dal comune, umanamente e musicalmente, lo rende unico e come tale diventa più inseguito che inseguitore. Lontano dalle mode, ha sempre ignorato pubblico e musica commerciale, ritagliandosi attorno a se un nutrito e selezionato numero di attenti ascoltatori. Del resto, e la sua opera lo dimostra in modo inequivocabile, Tom è personaggio complesso oltre ogni dire, indefinibile, indecifrabile.
A cinque anni da Orphans, una raccolta in 3 CD con 56 canzoni di cui metà nuove, Bad As Me esce nella stagione più ideale: l’autunno. Il disco infatti, abbandonando i “rumori” in favore della “canzone”, meglio si armonizza con le atmosfere novembrine.
Bad As Me non appartiene al miglior Waits quello dei metà anni ottanta per capirci, quello di Rain Dogs e Frank’s Wild Years, i suoi due dischi più belli per il sottoscritto, ma è pur sempre un ottimo disco. Un album che alterna almeno quattro capolavori: Get Lost, Pay Me, Back In The Crowd e New Year’s, brani estremamente profondi, dove ritmo, fisarmonica, malinconia e struggente melodia creano un tutt’uno, regalandoci quattro ballate del miglior Waits d’annata. Sei ottime canzoni: Chicago, Talking At The Same Time, Bad As Me, Satisfied, Last Leaf e Hell Broke Luce, mettono in evidenza l’estro di Waits con brani dove la voce rauca e notturna, a volte sofferta, a volte romantica, sempre e comunque accompagnata da musica straordinariamente “Waitsiana”, mediano la sommatoria del disco. Le altre tre canzoni dell’album: Raised Right Men, Face To The Highway e Kiss Me, sono sottotono, e pur essendo buone canzoni, non riservano particolari emozioni.
La peculiarità dell’album è la sua frammentazione, un susseguirsi di immagine su immagine, ognuna diversa, fino a far prendere al disco il contorno bel definito della sua “storia”. Waits scatta semplicemente delle istantanee, accontentandosi di dare un frammento d’atmosfera, uno scampolo d’emozione, racconta però dei particolari, e qui risiede la grandezza dell’autore, pur se l’accostamento di stili e radici sono diversi tra loro, la musica creata ha un suo senso e la poesia è la coordinata preferita.
Nel complesso il disco è ben suonato, possiede una personalità e dimostra che Tom Waits non ha rinunciato a scrivere ottima musica. Certo non è un capolavoro, ma di questi tempi, con trentotto anni di musica alle spalle e una ventina di album pubblicati, è come lo fosse.
Home – Identità Digitale Sono su: Mastodon.uno - Pixelfed - Feddit