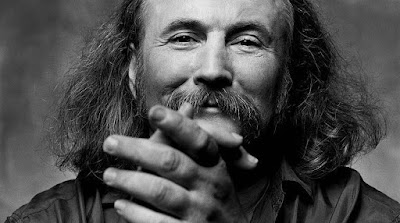Così adesso sono morto, cavoli, e nella tomba vicino alla mia c’è nientemeno che Chopin. Se me l’avessero detto quand’ero piccolo non ci avrei mai creduto. A parte che grande non sono diventato mai, ché anche a trentasei anni ero alto un metro e due centimetri.
Certo che morire a trentasei anni non è mica uno scherzo, è come un racconto breve che finisce subito, è un po’ presto, cavoli, morire a trentasei anni. Ma d’altra parte lo sapevo già, lo sapevo già che finiva male, la mia vita. La mia vita è cominciata male dall’inizio, sì, perché già quando sono nato mi sono rotto in mille pezzi, mi sono sbriciolato come un biscotto. Eh sì, perché le mie ossa avevano poco calcio dentro, e così sono sempre stato come una meringa, che appena la tocchi va in frantumi. Osteogenesi imperfetta,la chiamarono, che poi vuol dire che c’hai le ossa che sembrano grissini.
Ero brutto già da piccolo, io, perciò ero goloso di bellezze. Guardavo sempre la televisione, ché lì dentro c’erano un sacco di bellezze. C’erano le donne coi capelli lunghi e gli occhi grandi, e c’era la musica che mi piaceva. Quando avevo quattro anni alla televisione una volta c’era Duke Ellington che suonava, ed è stato lì, è stato proprio lì che mi sono innamorato del pianoforte, e così ho chiesto subito a mio padre se me lo regalava. I miei me ne comprarono uno, certo, ma siccome era un pianoforte giocattolo io dalla rabbia presi il martello e lo sfasciai, perché anche se avevo solo quattro anni volevo un pianoforte vero, io.
Il piano vero me lo regalarono, solo che ai pedali non ci arrivavo, cavoli, allora mio padre costruì una prolunga che se coi piedi la schiacciavi si schiacciavano pure i pedali. E, quel piano allora Io suonai talmente tanto che anche quando non lo suonavo non smettevo di pensarci, perché mi si era infilato dentro il sangue. “Ti mando a lezione di musica classica, allora, Michel”, fece mia madre, e io ci andai, ci andai per otto anni, ci andai, ma a casa la sera ascoltavo i dischi jazz di mio padre, che mi piacevano di più. Mio padre aveva un negozio di strumenti e suonava la chitarra, era bravo, e aveva un bel mucchio di dischi. Io li ascoltavo ogni giorno e li sapevo tutti a memoria, ma mio padre non ci credeva. Sentiamo, fece una volta, e io attaccai e cantai tutti i pezzi, glieli cantai uno dietro l’altro. “Merda!”, disse lui, e poi non disse niente più.
Quando in negozio veniva qualcuno per comprare un piano mio padre mi chiamava e mi diceva: “Faglielo sentire, ragazzo, dai”, e io mi mettevo seduto e attaccavo, facevo qualche numero di jazz di quelli giusti e quello lì restava secco, cavoli, ascoltava con la bocca aperta e alla fine il piano poi se lo comprava. Stavo sempre in negozio, stavo sempre con le mani sopra i tasti. E se smettevo era solo per ascoltare un disco. A scuola i miei non mi mandarono, per non farmi prendere in giro dai compagni.
Siccome a scuoia non ci andavo, da scuola mi mandavano le cassette con le lezioni registrate, ma io nemmeno le ascoltavo, le cassette. Ci registravo sopra la musica che suonavo, così potevo riascoltarmi. Mi riascoltavo e calcolavo la differenza tra me e Bill Evans, che col piano ci faceva le magie, e sempre mi pareva lui più bravo.
Poi un giorno arrivò Terry. Quando il trombettista Clark Terry capitò dalle mie parti, il suo pianista mangiò qualche schifezza e gli venne la cagarella, e allora Terry cercava un pianista per farsi accompagnare, e la gente gli disse che in zona c’ero io, ma lui disse che un ragazzo di tredici anni era troppo piccolo per accompagnarlo, e che la cosa non si era mai vista da nessuna parte. E quando poi mi vide disse che sembravo ancora più piccolo di uno di tredici anni, e che con uno così proprio non ci avrebbe mai suonato.
Ma quando mi piazzarono sullo sgabello e cominciai a darci dentro, disse che uno così bravo non l’aveva mai sentito, e cavoli, se potevo andare. Clark Terry mi piaceva, gente, era un tipo a posto, aveva cominciato a suonare da ragazzo, nei bar e poi nella banda della Marina Militare, ma poi aveva suonato anche col grande Duke e adesso mi voleva, voleva proprio me. Così entrai un po’ nel giro, e a quindici anni suonai pure con Kenny Clarke, un nero che era uno che picchiava forte sulla batteria e pure sul vibrafono, e che aveva inventato un nuovo modo di suonare il piatto della batteria. Ragazzi, la faceva parlare, la faceva.
A diciott’anni me ne scappai di casa, presi la mia roba e me ne andai a Parigi dove registrai il mio primo album. Cominciai a suonare Pure con Lee Konitz, uno che aveva imparato la fisarmonica da solo, e dopo il clarinetto e dopo anche il sassofono, e col sassofono ci sapeva fare, ragazzi ci sapeva.
E pure se non avevo soldi e camminavo male a diciannove anni presi l’aereo da solo, il biglietto lo pagai con un assegno a vuoto e me ne andai in America, perché era lì che c’erano i grandi jazzistti, lo sapevo, e io volevo suonare insieme a loro.
E lì incontrai Charles Lloyd, che ormai faceva l’hippy in mezzo ai boschi e che era triste e non suonava più perché il suo pianista lo aveva abbandonato, e quando arrivai per colpa mia ricominciò a suonare il sax con me e con altri due matti e insieme facemmo un bel quartetto. Suonammo in un mucchio di città, e sempre andava alla grande, e quando suonammo a Montreaux il mio nome all’entrata era scritto grande sulla porta, Michel Petrucciani, e su un giornale scrissero che quel concerto dimostrava la vera statura che avevo raggiunto in così poco tempo, e mi ricordo che quando a colazione sul giornale lessi la parola statura mi andò la spremuta di traverso e dalle risa caddi pure dalla sedia, e a momenti mi rompevo. Suonai con loro per tre anni e dopo me ne andai e cominciai a suonare solo.
Lo amavo, il pianoforte. Alle prove toccavo quella cassa lucida. Quando guardavo dentro ci vedevo i denti del pianoforte che rideva. E quella tastiera così lunga. Avevo un callo osseo nella spalla che non mi lasciava allargare bene il braccio, e ai concerti, per arrivare in fondo alla tastiera, saltellavo sul sedile come un merlo. La gente, siccome mi sporgevo, aveva paura che cadessi, ma non cadevo mai, perché con l’altra mano mi tenevo al pianoforte. Una volta che il pubblico lo sentivo tutto teso, mi fermai e chiesi:
“Come va?”
Allora tutti risero e si misero più comodi sopra le poltrone, e io continuai.
Ai concerti c’erano sempre donne belle che mi portavano sul palco, mi portavano in braccio come un bambino, tanto pesavo solo venticinque chili, ma poi a venticinque anni imparai a camminare con le stampelle, e da allora sullo sgabello mi arrampicai da solo, senza paura, perché alle mie mani veniva sempre una gran voglia di toccare i tasti. Quando mi portavano sul palco, anche se ero francese mi sentivo napoletano e spaccone come mio nonno che pure suonava la chitarra, e appena cominciavo a suonare dicevano che si vedeva proprio che ero preso dalia musica, ecco, che si capiva da come tenevo alta la testa con gli occhi persi dentro l’aria, senza guardare la tastiera. Ma io la testa la tenevo alzata solo per respirare meglio, se no l’ossigeno mancava.
A volte un osso si rompeva, mentre suonavo, una clavicola, che so, una costola, una scapola, ma il dolore io me lo tenevo e stavo zitto, e di suonare non smettevo mai, perché era bello come quando fai l’amore.
E una sera dopo un concerto c’erano due ragazze, una con le fossette e una col codino, e quella con le fossette mi guardò e aveva gli occhi neri neri, e si chiamava Erlinda, e le sorrisi, e lei davanti a tutti mi prese in braccio e mi baciò. E così dopo un po’ ci sposammo. Non era una donna qualsiasi, Erlinda Montano. Era un’indiana Navajo, cavoli, una pellerossa. Una pellerossa e un nano, ragazzi, ci pensate? Avevo ventun anni, allora, e uscì un mio disco che aveva dentro un pezzo che si chiamava Erlinda come lei. Lei lo ascoltò e sorrise, e fece le fossette.
E con Erlinda ero felice e andavo al mare, e al mare mi compravo camicie a fiori e camicie con le palme, camicie hawaiane con le maniche corte che mi sentivo subito in vacanza. E non le compravo nei negozi dei grandi, le camicie, no, le compravo nei negozi per bambini. Ah, ci stavo così bene, con Erlinda.
E dopo venne Eugenia, che mi diceva sempre che sotto le coperte ci sapevo fare, e fare l’amore mi piaceva, perché era proprio come suonare il pianoforte. E quando le facevo le carezze Eugenia diceva che mani calde, Michel, che mani calde, e davvero me le sentivo calde, le mani, come ci fosse dentro la musica bollente che voleva uscire.
E anche a Eugenia dedicai un pezzo che si chiamava Eugenia come lei. Mi piaceva un sacco, Eugenia, e restai con lei per cinque anni, e la lasciai il giorno prima delle nozze perché avevo conosciuto Marie-Laure, che mi diede un figlio, Alexander, con la mia stessa malattia. Eugenia pianse a più non posso, quando le dissi che la lasciavo, ma che potevo farci, uno non può voler bene quando non vuole bene. Adesso stavo con Marie-Laure, la amavo, e quando le chiedevo se mi trovava bello, Marie-Laure diceva che ero bellissimo, e che la musica mi stava dentro come un fiore dentro un vaso, e quando usciva profumava.
Suonare mi faceva stare bene, ragazzi, non ve l’immaginate, le mani diventavano di fuoco. Con le mani sui tasti ero felice.
Componevo. Una volta scrissi un pezzo lento di sole quattro note che mi piaceva tanto. Forse era il più bello, perché era bello e semplice, e dolce come una poesia. Cantabile, si chiamava, Cantabile, perché veniva voglia di cantarlo come una canzone, anche se non aveva le parole.
E un giorno a Bologna insieme a Lucio Dalla suonai pure davanti al papa, e Lucio suonò il clarinetto che sembrava che piangeva, e io suonai come una preghiera. Alla fine Giovanni Paolo era commosso, e anch’io ero commosso, e mi volevo inginocchiare e non riuscivo. E mi ricordo che mentre suonavo i monsignori battevano il tempo con il piede, e con le mani facevano oscillare a tempo le sottane e, cavoli, ci mancava poco che si alzassero e si mettessero a ballare.
Quando suonavo certe volte mi mettevo in testa berretti strani, coppole da siciliano e cappelli grandi che sembravano sombreri, e ci sudavo dentro ma non me li toglievo, me li tenevo stretti e andavo avanti, e sudavo di brutto dentro le camicie che alla fine erano bagnate che se le strizzavi usciva l’acqua, e scendevo dal palco sudato marcio, e quando scendevo dal palco non ero mai solo, perchè le donne mi volevano, mi correvano dietro, gente, per i baci e per gli autografi, e così dopo Marie-Laure venne Gilda, e pure lei suonava il piano, suonava musica classica e le piaceva Chopin. Era siciliana, insegnava al conservatorio, e senza che mi avesse mai parlato prima mi disse che da molti giorni mi seguiva, perché una volta a un concerto il ricordo delle mie mani Ie era rimasto come una compagnia. E le volevo così bene che me la sposai, Gilda, me la sposai e dopo un poco divorziammo.
E per ultima venne Isabelle, con gli occhi chiari, Isabelle che mi voleva bene più di tutte, che cercò di farmi vivere in una casa parigina e cercò di farmi smettere di bere e di drogarmi.
E tutte queste storie le volevo perché volevo vivere storie d’amore con delle donne belle, storie d’amore come quelle che vedevo alla televisione, dove lo sposo prendeva la sposa in braccio, la portava nella stanza e dopo si baciavano. Solo che le mie donne erano loro a prendere in braccio me, e io volentieri le lasciavo fare.
Volevo dormire con delle donne belle, cavoli, ma certe notti dal dolore nelle ossa non dormivo, e quelle notti che arrivavano una dietro l’altra la spalla, i nervi, il polso, l’osso del ginocchio li sentivo a uno a uno. Solo le mani erano forti e sempre calde.
Però ai concerti suonavo e suonavo, ragazzi, dovevate esserci, e le note dalla cassa del mio piano uscivano come ombre che avevano la voce, e salivano in alto e poi cadevano giù, ed erano una pioggia scoppiettante che cadeva a catinelle sulla gente che ascoltava, sulle mie ossa rosicchiate, sul mio cuore.
Suonare era bello, era la mia vita. Coi piedi andavo piano, si capisce, ma con le mani andavo a cento all’ora e le sentivo sempre calde, le sentivo, le mie mani, e la tastiera Ia vedevo che fumava. Suonavo e me ne andavo per il mondo, e in tutto il mondo tenevo un sacco di concerti, e solo nell’ultimo anno di concerti ne contai duecentoventi.
Suonare suonavo, suonavo sempre. Mi arrampicavo sullo sgabello e poi partivo come un razzo, andavo in orbita. Avevo sempre i riflettori in faccia, mentre suonavo, e nel buio non vedevo niente, ma quelli giù dal palco nel buio li sentivo che trattenevano il respiro, mentre picchiavo sopra i tasti, e non tossiva mai nessuno, non tossiva, e nessuno si soffiava il naso mai.
E quando cominciavo dalle dita mi usciva fuori tutta quella musica, mi usciva, veniva fuori come acqua fresca, bagnava la tastiera e andava giù sul legno delle tavole del palco, colava giù sul pavimento e bagnava i piedi degli spettatori a uno a uno, e gli saliva per le gambe e andava su, e a quelli gli veniva freddo, e alla fine con le luci accese li vedevi tutti bagnati, in piedi, tutti inzuppati che battevano le mani. E dopo le donne venivano nel camerino e mi baciavano. E lo sapevo ch’ero brutto, ma con la musica e le donne mi veniva tutta la bellezza.
Guadagnavo bene, guadagnavo. Da non crederci. Mi davano un sacco di soldi, ragazzi, e quando suonavo con gli altri musicisti dividevo sempre in parti uguali, anche se loro non erano famosi come me. E con la limousine si andava negli alberghi a quattro stelle e come mi piaceva. In camera schiacciavo tutti gli interruttori e accendevo tutte le luci insieme, accendevo, e dopo aprivo il frigo e mi bevevo tutto quel che c’era, e ogni sera facevo il bagno nella vasca con la schiuma dentro.
Una volta a Bergamo mentre suonavo mi ruppi il braccio destro, ma nessuno se ne accorse, perché suonai tutto il tempo con il braccio rotto come niente fosse. A un altro concerto una sera suonammo per due ore, faceva un caldo boia e sudai come una fontana. Le mani mi scottavano, la testa pure, ero stanco e avevo mal di schiena, e avevo solo voglia di tornarmene in albergo e di sdraiarmi a letto. Ma quelli chiesero il bis, e poi un altro bis e un altro ancora, e così suonai ancora per mezz’ora, suonai, e a casa il medico disse che mi ero rotto il coccige, che è l’osso del sedere, l’ultimo osso della schiena prima del culo.
Dopo i concerti il mio medico mi visitava, scuoteva Ia resta e diceva basta, Michel, basta, non puoi andare avanti in questo modo. E dopo con le mani in tasca andava su e giù per lo studio, mi guardava storto, si arrabbiava e mi proibiva di fare altri concerti, e io invece sorridevo e li facevo. Li facevo perché erano la mia vita, i concerti, come il cibo, le donne e gli amici.
Mi piaceva, la vita, cavoli. Mi piacevano un sacco di cose. Suonare, fare l’amore, stare con gli amici. Anche mangiare, mi piaceva, e a casa a volte venivano gli amici e cucinavo io, e si mangiava e si beveva alla grande, col vino, i dolci e la pasta fatta in casa, e il piatto che facevo meglio era il Pollo alla Petrucciani, che ti leccavi i baffi. E quando cucinavo il pollo mi ci mettevo di gusto, mi ci mettevo, e lo facevo bene, e farlo bene era più difficile che suonare il piano. Mangiavamo e bevevamo, e a un certo punto c’era sempre qualcuno che suonava.
E, dopo mangiato, quando tutti se ne andavano, giocavo sul tappeto con mio figlio Alexander, e giocavamo piano perché aveva le ossa di ricotta come me, e un giorno, mentre giocavamo piano, all’improvviso fece la faccia triste, guardò sua madre e disse: “Perché mi hai fatto?”
Andavo a tutta birra, suonavo dappertutto e con tutti, ormai. Quando suonai con Dizzy Giilespie vidi che aveva una tromba tutta storta, e gli chiesi ma come fai a suonare? E lui rispose che era stata la moglie che gliel’aveva stortata picchiandola sul pavimento, e che da allora la tromba suonava molto meglio. Suonai con Miies Davis che con la tromba faceva venire Ia malinconia. E, poi suonai al Blue Note, che non me lo sarei mai sognato, il Blue Note, cavoli.
Mio padre era orgoglioso, diceva che ero proprio bravo, con il piano. Che ero il migliore. “Quando non ci sarò più”, diceva, “tu suona, suona sempre, Michel, e mentre suoni ricordati che sarò sempre sopra di te che ti guardo da là sopra”.
E, invece adesso sono io che da qua sopra guardo lui.
Venne un Natale, e Natale io lo odiavo, perché da bambino a Natale e a Capodanno ero sempre in ospedale con qualche osso rotto.
Finalmente venne un Natale che ero tutto intero e avevo solo un po’ di raffreddore, e dopo venne Capodanno, e a Capodanno, per andare a passeggiare in spiaggia con la mia donna per mano, mi beccai quella polmonite, e sulla spiaggia caddi a terra come un fico secco. Mi tirai su da terra e le cose non erano più cose, erano ombre. Allora Isabelle mi prese in braccio e mi baciò, e dopo andammo all’ospedale. Seduta sulla sedia aveva quello sguardo strano, che usciva da quegli occhi chiari pieno di paura. E dal letto la guardavo che piangeva con quegli occhi grandi e chiari e sorridevo e pensavo che io così brutto ero felice di avere vicino una donna così bella, e pensavo che sempre avevo avuto accanto donne belle. E poi il 6 gennaio da sotto la coperta le dissi che avevo freddo alle mani e le chiesi se me le voleva riscaldare.
Lei allora prese le mie mani nelle sue e me le scaldò, e dopo uscì un momento a prendermi un caffè, e io proprio in quel momento sono morto, cavoli, il 6 gennaio, e adesso qui vicino a Chopin mi viene da ridere, a pensarci, perché io, pieno di donne belle, sono morto proprio mentre arrivava la befana.
tratto da: Antonio Ferrara, in “Parole Fuori” edizioni Il Castoro, Milano, 2013
#Dimusica
Home – Identità Digitale
Sono su: Mastodon.uno - Pixelfed - Feddit