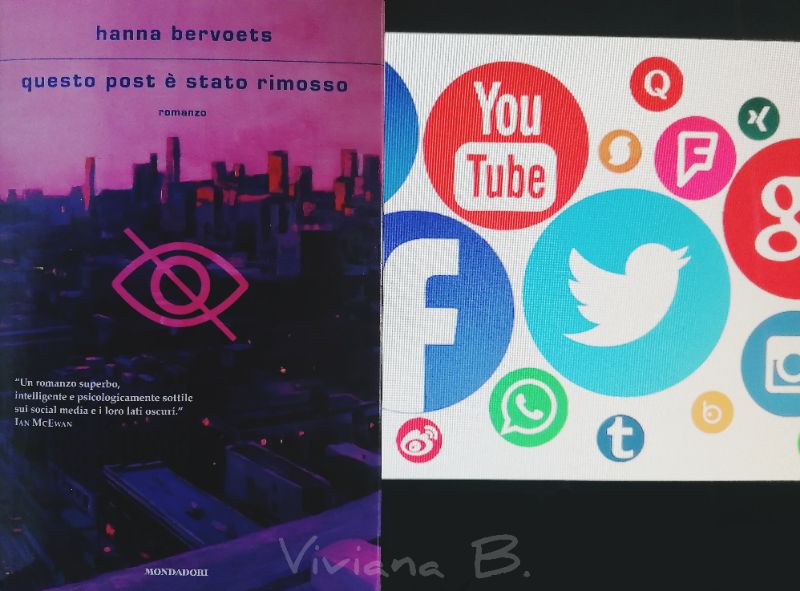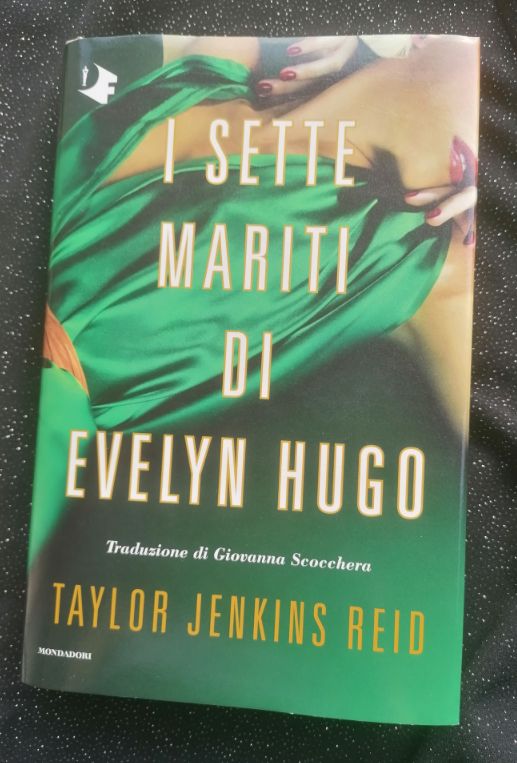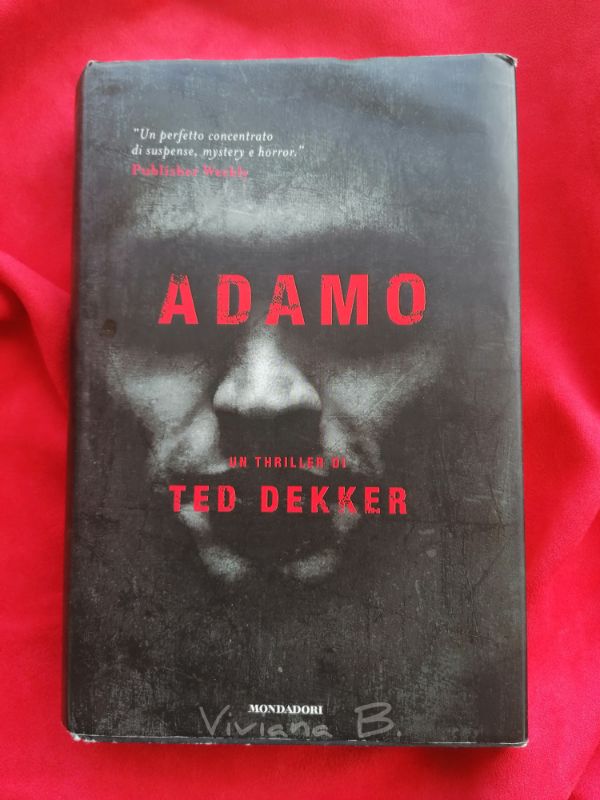“Il mito di Atlantide e i continenti scomparsi” di Lyon Sprague de Camp
Fin da quando fece la sua comparsa nel racconto di Platone, Atlantide non ha mai smesso di affascinare l’umanità e, nei secoli, non sono certo mancati i ricercatori – più o meno degni di fiducia – che hanno creduto di poterne identificare la collocazione geografica in questo o quest’altro punto del pianeta. Anche se potrà sembrare ridondante per molti, spendo qualche parola su cosa dovrebbe essere stata Atlantide, perché, proprio per il fascino suscitato e la grande quantità di decenni trascorsi dalla sua nascita platoniana, nei secoli questa è mutata parecchio, diventando a volte isola altre continente, spostandosi a volte nel Mediterraneo o appena fuori da esso altre in pieno Oceano Pacifico o persino al Polo e così via. Secondo Platone (e qui vi piazzo il link perché un’ulteriore digressione sarebbe davvero troppo!) oltrepassate le Colonne d’Ercole si sarebbe trovata una serie di isole, la più estesa delle quali, “più grande della Libia e dell’Asia messe insieme”, era una forte potenza marinara il cui primo re fu Atlante, figlio del dio del mare Poseidone. Il filosofo parla di questa civiltà nei suoi dialoghi Timeo e Crizia, entrambi datati attorno al 360 a.C., ma si riferisce ad Atlantide come a qualcosa di già passato: la grandiosa isola, infatti, sarebbe sprofondata ”essendosi verificati terribili terremoti e diluvi, nel corso di un giorno e di una notte”, dopo il fallito tentativo di vincere una guerra contro Atene; la vicenda è tanto remota che persino gli ateniesi ne avevano perso memoria e ne sono venuti a conoscenza solo grazie a Solone (VI secolo a.C.), che, giunto in Egitto, avrebbe incontrato alcuni sacerdoti che gli raccontarono tutto. Nel Crizia lo stesso Platone si riferisce ad Atlantide parlando di novemila anni prima.
Questo ci dà un’idea di come avrebbe dovuto essere Atlantide, almeno per estensione e ubicazione geografica, e dei tempi antichissimi in cui avrebbe potuto esistere questa civiltà che, sebbene evoluta e ben organizzata, era evoluta e ben organizzata per i tempi in cui scriveva Platone il quale, per inciso, non ha mai parlato di raggi laser né di uomini-pesce. Sgombrato dunque il campo da tutta – o almeno buona parte – della letteratura fantasy e fantascientifica, passiamo adesso ad occuparci della ”vera” Atlantide e di coloro che ne hanno intrapreso la ricerca, cui si riferisce questo libro.
Fintanto che c’è stato abbastanza mondo inesplorato, Atlantide ha potuto spostarsi a piacimento un po’ più in là, oltre il conosciuto e se ai tempi di Platone il continente scomparso si trovava appena superate le Colonne d’Ercole mano a mano che queste aree venivano esplorate l’Atlantide si doveva essere trovata altrove: in prossimità delle Canarie, poco distante dalle Americhe, nei dintorni dell’Australia… Nel libro vengono elencate – e smontate – le più disparate teorie, come quella dell’Atlantide-in-America, nata in buona parte grazie al monaco spagnolo Diego de Landa che, oltre a dare alle fiamme tutta la letteratura indigena che riuscì a trovare a partire dal 1562, si interessò poi alla lingua Maya e si inventò in buona sostanza un alfabeto inesistente. Ignatius T.T. Donnelly (1831-1901) dal canto suo teorizzò che i Maya e altre civiltà antiche discendessero dagli atlantidei, mentre il suo contemporaneo Augustus Le Plongeon asserì che una principessa atlantidea scampata alla distruzione della propria terra sarebbe riuscita a fuggire in Egitto, dove eresse la sfinge in memoria del fratello-consorte e, cambiato il proprio nome in Iside, fondò la civiltà egizia. Non mancano gli occultisti, tra cui spicca madame Helena P. Blavatsky, fondatrice a fine ‘800 della teosofia, la cui visione di Atlantide, della Lemuria e dei loro abitanti è tanto articolata e complessa che non mi basterebbero una dozzina di blog per esaminarla nel dettaglio (ma se voi volete cimentarvi nell’impresa potete leggere la sua opera La dottrina segreta).
Pur essendo Sprague de Camp un autore di fantascienza, l’analisi che fa in quest’opera è improntata a un forte realismo: storiografia e geografia, occultismo ed esoterismo vengono trattati con razionalità, i miti vengono analizzati e sezionati minuziosamente, conducendo alla realizzazione di un testo più di saggistica che di narrativa. Se cercate un romanzo d’evasione, non è certo questo il libro che dovete tenere tra le mani.
L’autore raccoglie, esamina e smonta pazientemente tutte le teorie sorte nei secoli attorno ad Atlantide e ai continenti scomparsi come Mu e la Lemuria, in un affascinante viaggio nel tempo, nello spazio e nei miti, tra ricercatori che hanno seriamente cercato di trovare un riscontro tangibile e concreto alle parole di Platone e truffatori che hanno imbastito favole affascinanti per raggirare i creduloni. La conclusione di Sprague de Camp è che Atlantide non sia mai stata altro che un mito, un’invenzione di Platone per suffragare le proprie teorie filosofiche, ma, scrive anche, L’Atlantide offre il mistero romantico a coloro che giudicano la storia vera non abbastanza emozionante […] ma soprattutto fa vibrare le corde dell’animo umano con il suo concetto della malinconica perdita d’una cosa bella, di una felice perfezione posseduta un tempo dall’umanità e allora chissà che non possa essere di sprone, oggi, per guidare l’essere umano verso un miglioramento personale e sociale per il futuro.
Titolo: Il mito di Atlantide e i continenti scomparsi (Lost continents The Atlantis theme) Autore: Lyon Sprague de Camp Traduttore: R. Rambelli Editore: Fanucci Anno di pubblicazione: 1980
Viviana B.