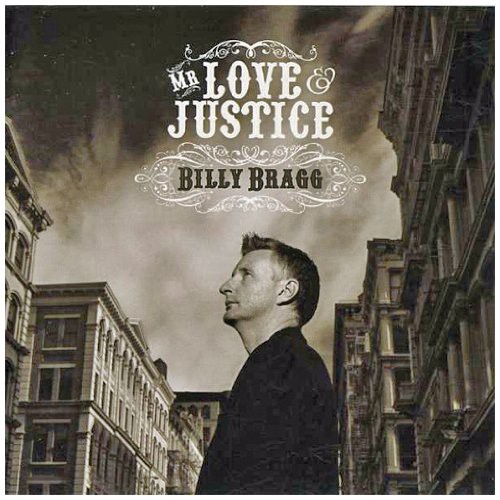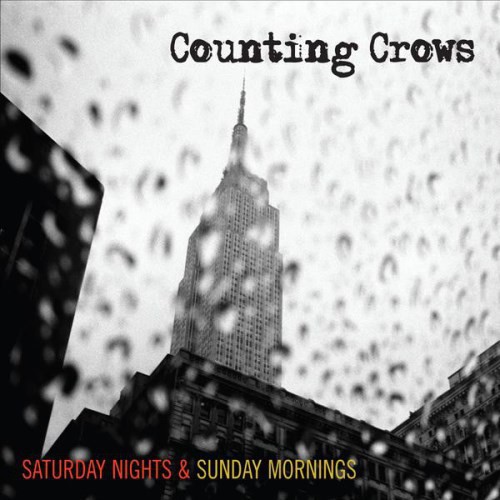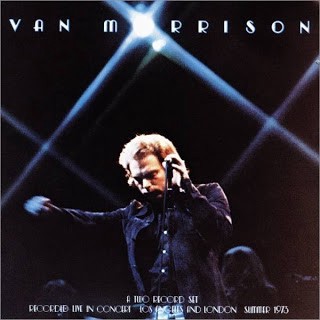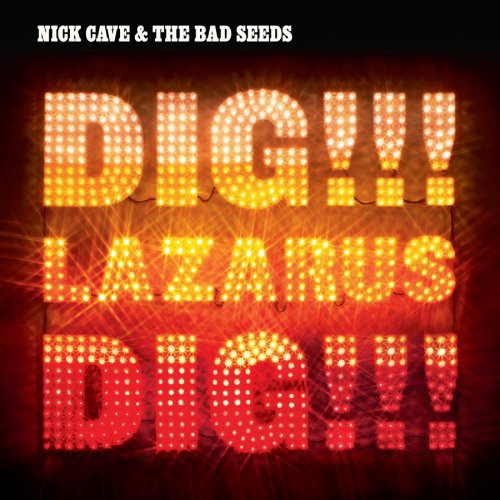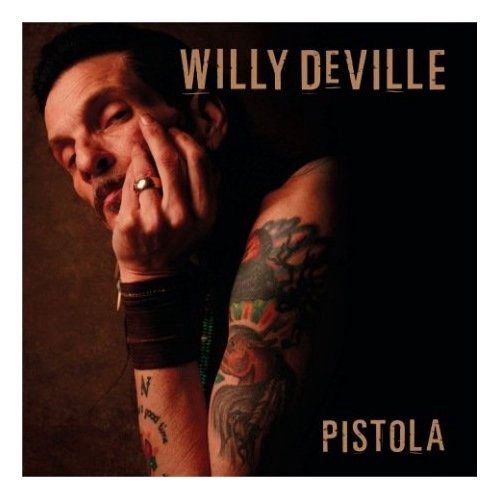Paul Simon — Graceland (1986)
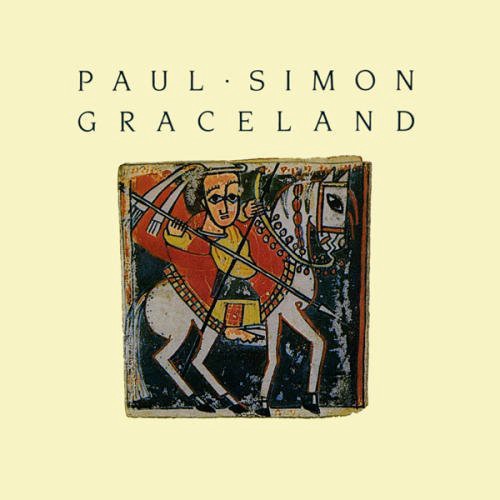
Oggettivamente questo disco è passato alla storia per due motivi: ha sancito la nascita “ufficiale” della world music ed è uno dei simboli del passaggio del Sudafrica alla democrazia. Per quel che mi riguarda c’è un terzo motivo: è grazie a questo album che è nata la mia passione per la musica africana.
Non è retorica dire che lungo le canzoni di “Graceland” è passata la storia, e non quella della musica, ma proprio la storia del Sudafrica. Oggi si comincia a dimenticare, almeno guardando da lontano, che è esistito un Sudafrica non libero e non democratico e, per chi non lo sa o non lo ricorda, questo è solo un disco di un cantautore americano con musicisti africani.
Ma allora no, allora nel 1986, Graceland suscitò passioni, rabbia, polemiche. Paul Simon ha sempre amato la musica di mondi diversi dal suo. Lo aveva già fatto anni prima insieme a Art Garfunkel, facendo scoprire a milioni di ascoltatori le malinconie andine aggiungendo parole alla melodia tradizionale di “El condor pasa”. Successivamente nel 1984 grazie a un disco scoprì per caso la musica dei ghetti neri di Johannesburg.
Ne fu talmente affascinato che volle andare sul posto per registrare qualcosa insieme ai musicisti locali. Ma nei confronti del Sudafrica era in atto un embargo e suonare significava appoggiare indirettamente il regime segregazionista. Ci fu poi la polemica che dipingeva Simon come il bianco ricco che si può pagare tutti gli sfizi che vuole sfruttando la musica altrui. Il dibattito diventò caldissimo, diversi musicisti inglesi attaccarono senza mezzi termini il collega americano e qualcuno notò come nei testi mancasse il minimo accenno alla situazione sudafricana.
Oggi la storia ha dato ragione a Simon; Graceland è tradizionalmente considerato l’inizio ufficiale della world music nonché uno dei simboli del passaggio del Sudafrica alla democrazia. Musicalmente parlando è un bel disco, pieno di melodie nitide e a volte memorabili, rese intense dalle voci pirotecniche dei Ladysmith Black Mambazo e scintillanti dai riff chitarristici di Ray Phiri.
Home – Identità Digitale Sono su: Mastodon.uno - Pixelfed - Feddit