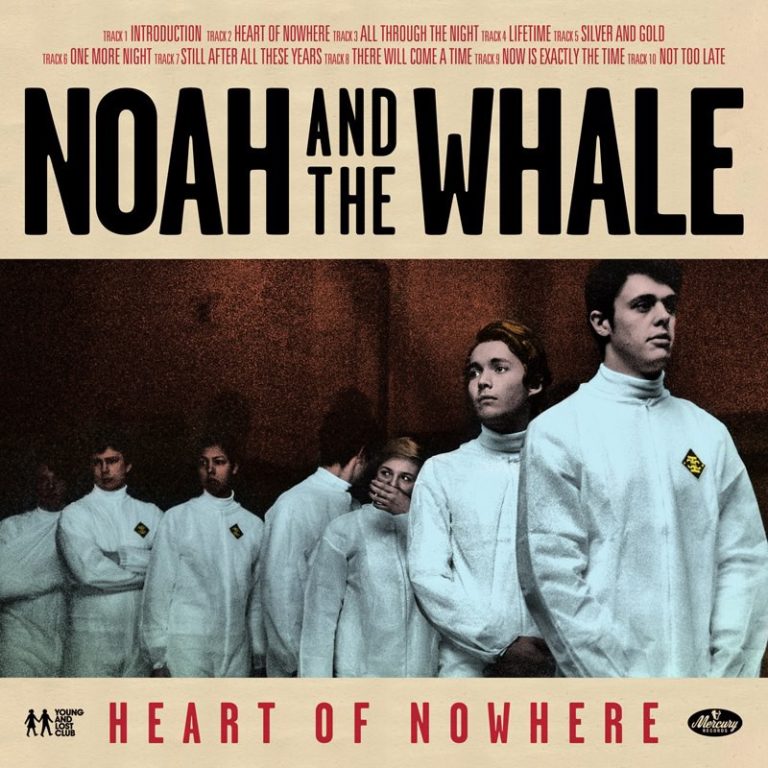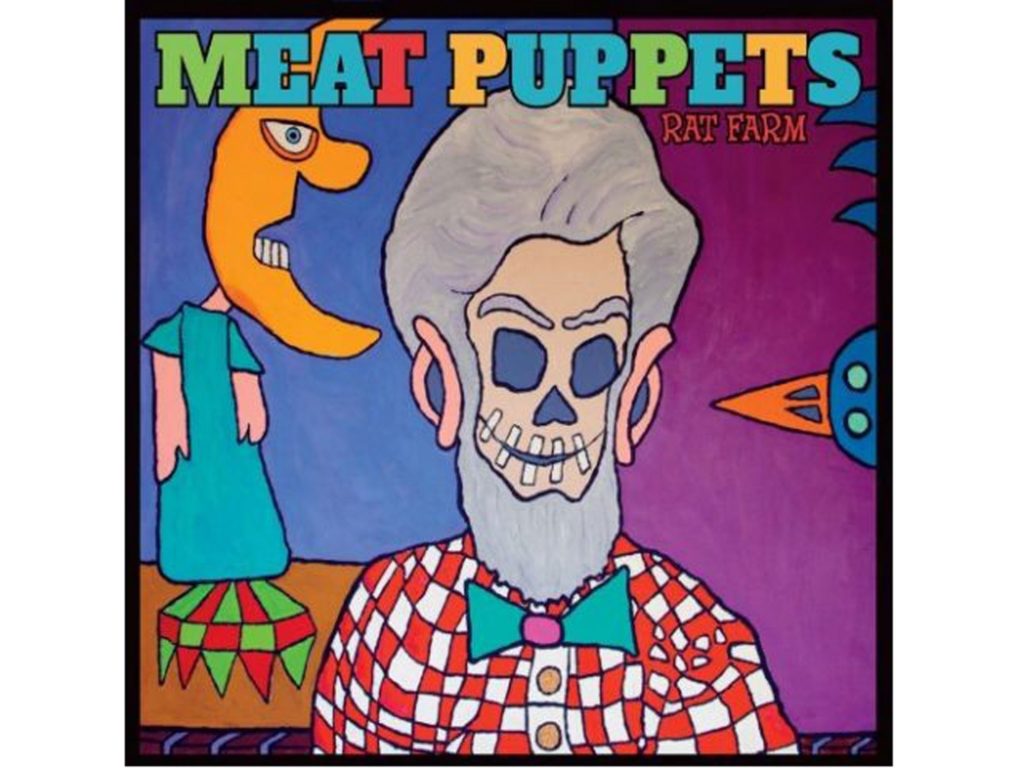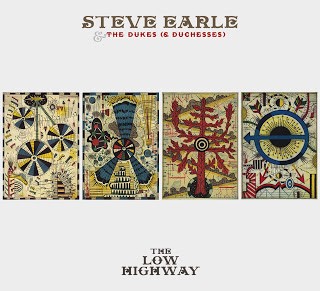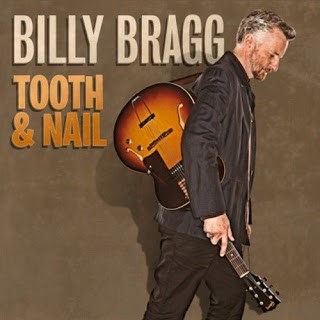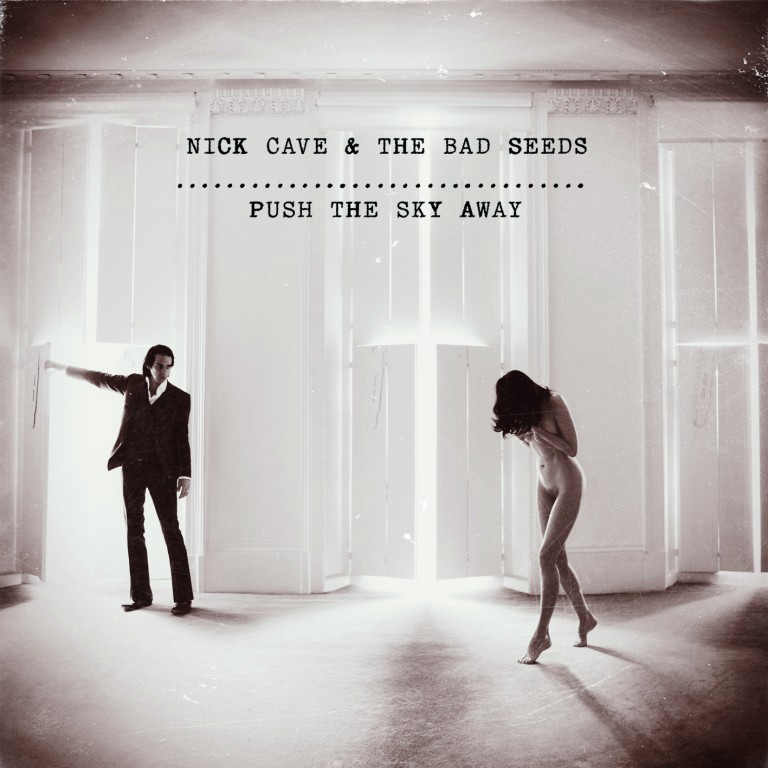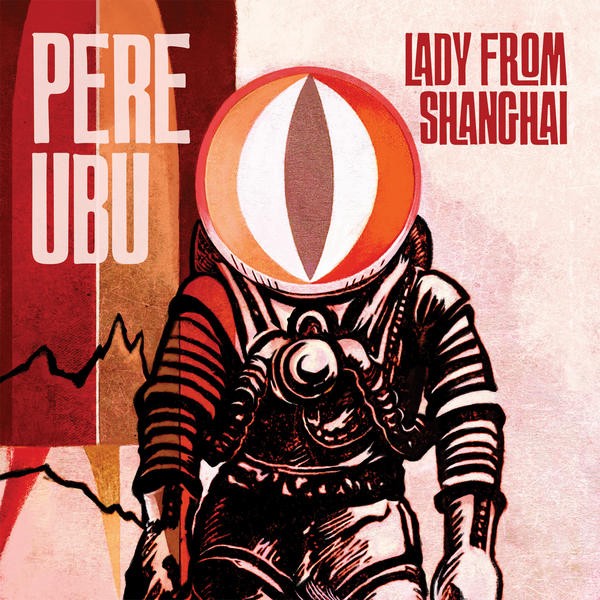The National — Trouble Will Find Me (2013)

Dopo l’ottimo Hight Violet e lasciati per il momento i loro progetti personali, ritorna una delle mie band preferite: The National.
Attivi dal 2001 con il disco Omonimo e successivamente con Sad Songs for Dirty Lovers, è con Alligator che cominciano la scalata verso la notorietà. Con i successivi Boxer e il sopra citato Hight Violet e grazie ai consensi di critica e pubblico, i The National vengono definitivamente consacrati nell’olimpo della musica degli anni duemila. Le due coppie di gemelli: Dessner & Devendorf, la voce bellissima e inconfondibile di Matt Berninger, riescono ancora una volta a farsi apprezzare con i tredici brani che compongono l’album.
Per paradossale che vi possa apparire, gruppi come questo sono i più difficili da ‘inquadrare’ e ‘giudicare’ (ahi, che parolaccie). Perchè? Perché sono più scivolosi delle saponette, quando credi di esserti lavato davvero la schiuma dalle mani ti trovi sul palmo un segno profondo. E allora devi rifare tutto da capo.
Al primo ascolto di Trouble Will Find Me dà subito l’esatta misura del carisma posseduto dalla band di Cincinnati, che mostra di aver definitivamente affilato le proprie sonorità. Almeno un paio di composizioni sono da considerare capolavori, un’altra manciata sono di ottimo livello e le restanti non sono in nessun caso di serie B, e questo solo al primo ascolto, poi man mano che lo si approfondisce, ci si rende conto che si ha a che fare con un grande disco.
L’intero album scorre vellutato con l’attenzione concentrata sull’elemento melodico, sulla stesura di riff solidi e lineari e sulle sonorità delle chitarre elettriche, nobiliato dall’interpretazione vocale di grande pregio di Berninger.
Nella inspiegabile logica dei corsi e ricorsi, i The National sembrano voler ritornar con un passo alle radici del loro percorso musicale, recuperando quel modo di essere, spontaneo un po’ sanguigno, da giovani universitari, che segnò il loro esordio e allo stesso tempo, sembrano voler mettere un passo in avanti a mo’ di ‘rigenero’, come linfa vitale di rinnovamento.
E’ una mostra di quadri Trouble Will Find Me, è musica colorata, con alcune pennellate gioiose e altre meno, un’esposizione di arte pittorica con l’intento di raccontare la realtà attraverso i quadri/canzoni.
Un nuovo ottimo lavoro, robusto e affiatato, molto curato nel suono e nella lirica, un buon concentrato di tutti i dischi finora pubblicati, in poche parole un ‘the best’.
Home – Identità Digitale Sono su: Mastodon.uno - Pixelfed - Feddit