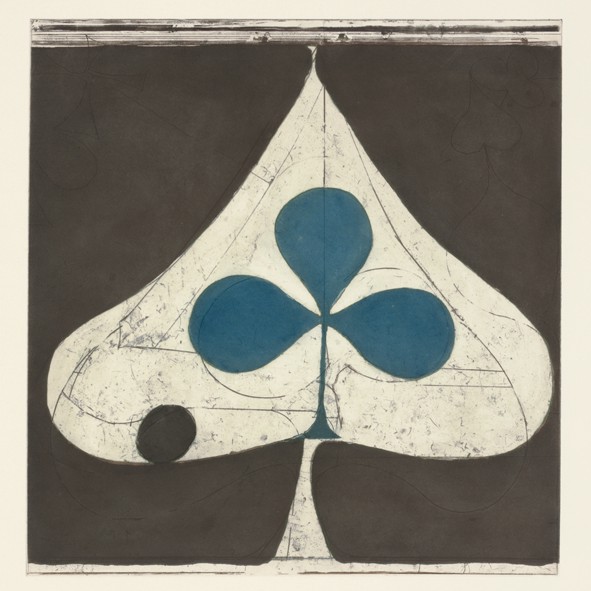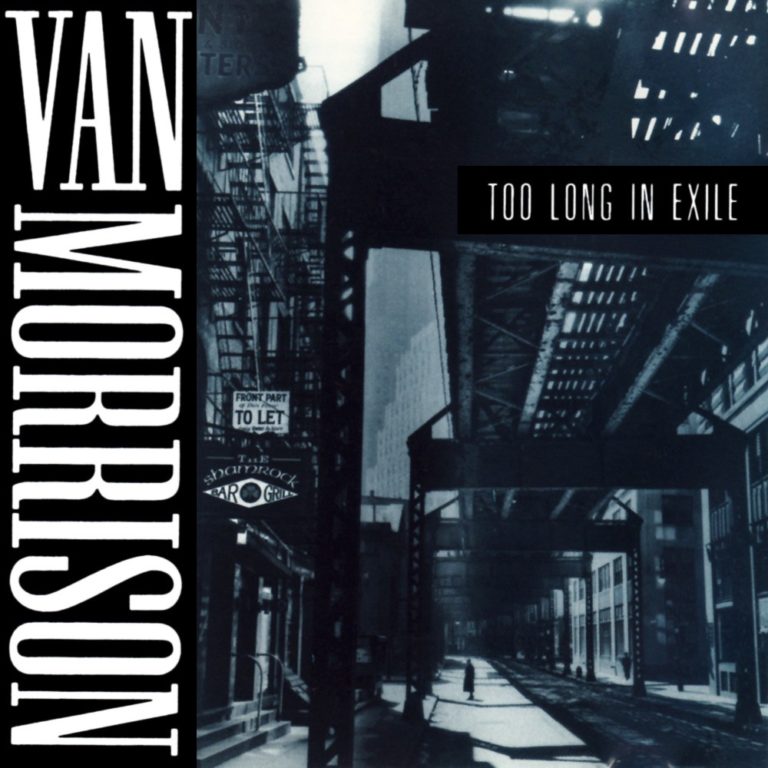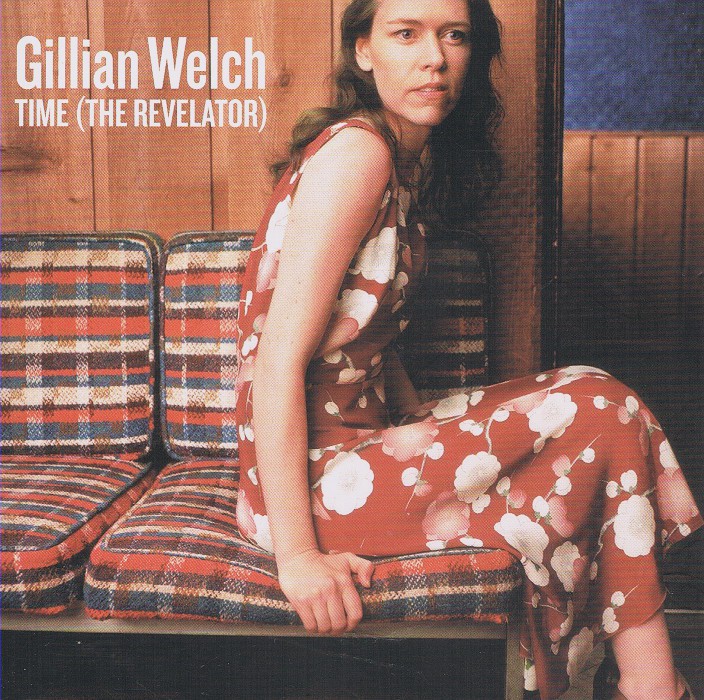Yo La Tengo — Fade (2013)

Di tanto in tanto capita di ascoltare un album di cui non si ha voglia di parlare temendo un confronto tra di esso e le proprie parole. Questo succede quando un disco comunica qualcosa non appena comincia a suonare e subito uno si sente partecipe delle emozioni dell’artista e gli regala candidamente le proprie, e anche dopo aver ascoltato un solo brano hai la certezza che tutto il resto sarà buono. Questo è uno di questi.
Vicini al trentesimo anno di attività (si sono formati nel 1984), i Yo La tengo pubblicano il loro sedicesimo album in studio che porta il bel titolo di Fade ovvero “dissolvenza”.
Il trio composto da Ira Kaplan (chitarra, piano, voce), Georgia Hubley (batteria, pianoforte, voce) e James McNew (basso, voce), non ha mai amato la luce dei riflettori dello show business e proprio per questo non hanno mai avuto un grande successo commerciale diventando quindi una band di culto.
Tra le band più interessanti degli ultimi vent’anni, i Yo La Tengo hanno la peculiarità di avere creato un “sound” personale frutto di vari stili. Una sommatoria sonora intensa e colorita, carica di riffs strumentali e vocali. Una musica che appare spazializzata in seno ad un discorso netto e curato con particolare abilità specialmente nel fondere l’acustico con l’elettrico. Relegate in parte le chitarre in favore ad una sezione di archi e fiati, il suono è più omogeneo, delicato e romantico. I brani, in tutto dieci, sono sempre piuttosto centrati in questa ottica e l’assenza di “pecore nere” è un altro punto a favore del collaudato e acquisito professionismo della band.
Un album fluido, piacevole, coeso, ricco di dettagli, tra i più completi e riusciti che la band abbia registrato.
Home – Identità Digitale Sono su: Mastodon.uno - Pixelfed - Feddit