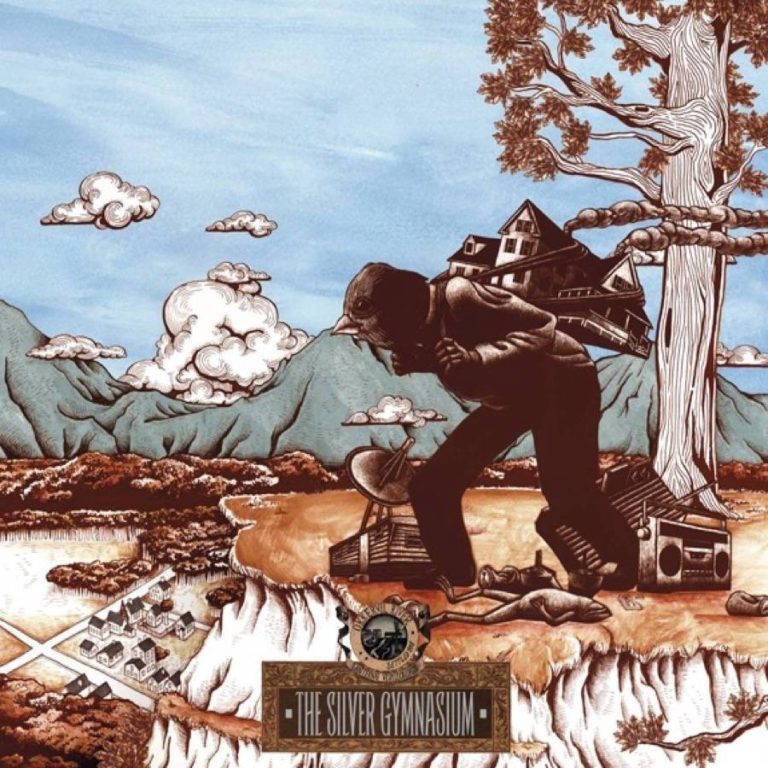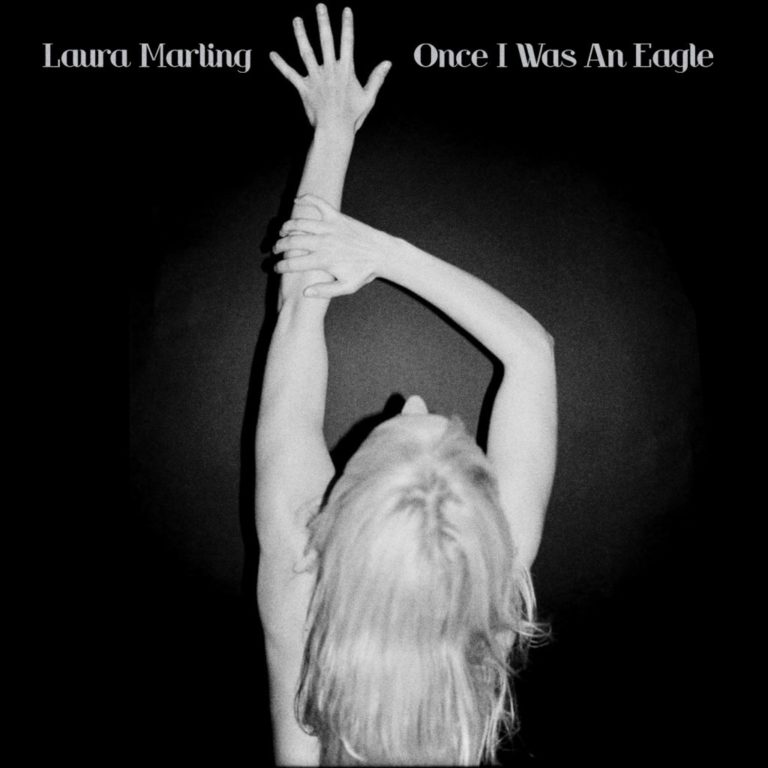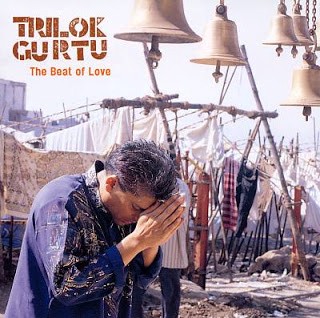A quattro anni da Keep it Simple ultimo suo disco in studio, esce Born To Sing: No Plan B, album registrato interamente in presa diretta nel castello di Culloden in Irlanda e precisamente a Belfast sua città natale. Per questo lavoro, Morrison ha scelto e non a caso, l’etichetta jazz Blue Note. Il “suono” infatti, è prevalentemente influenzato di jazz, oltre che di soul e blues “toni” a lui sempre cari.
Nel sottotitolo dell’album Born To Sing: No piano B, è indicato il potere che la musica ancora possiede per questa leggenda vivente chiamato “The Man”. Nessun Piano B infatti, è la prova concreta che non esistono secondi piani, l’assoluta convinzione per questo quasi settantenne musicista con cinquanta anni di carriera alle spalle e trentacinque dischi pubblicati, che, la musica con l’”M” maiuscola ha ancora un valore assoluto, supremo, e che, se esistono mode e modi che in qualche modo vogliono distogliere la sua vera essenza, la musica quella “vera” esiste ancora, senza se e senza ma.
Da vecchio fan di The Man, sarò sincero, non mi aspettavo un buon disco come questo, il nostro infatti, ultimamente non brillava di buona luce e un suono mediocre e stantio aveva avuto il sopravvento.
Fin dal primo ascolto, il comun denominatore che lega i dieci brani del disco è la maestria con cui è strumentalmente suonato. La band di sei elementi e in particolare i fiati di Chris White e Paul Moran rispettivamente al sax tenore e alla tromba, danno un tocco di eleganza di notevole spessore.
Se quasi la metà dei brani: Going down to Monte Carlo, Retreat and view, If in money we trust e Pagan heart raggiungono i sette/otto minuti e sottolineano l’incommerciabilità dell’album le restanti: Open the door (To your heart), Born to sing, End of the rainbow, Close enough for jazz, Mystic of the East e Educating Archie, ci fanno capire e dimostrano un vecchio musicista in piena forma e con ancora voglia di suonare.
Don Was, megaproduttore e ora discografico di Van Morrison, nell’ unica intervista che lo scontroso irlandese ha deciso di rilasciare per l’uscita dell’album, gli ha chiesto: Di cosa parla la tua musica? Ecco la sua risposta: “Finisco sempre per scrivere di… chiamiamola energia, perché il senso delle parole cambia continuamente. Oggi il Rhythm and Blues non è più quello che intendevo io, e neppure il Soul. Neanche le religioni usano più le parole di un tempo. Oggi tutto serve a intrattenere la gente, a farli preoccupare con la Reality Tv, che è televisione fatta da gente che si comporta come se fosse vero. Così la gente non ha neppure il tempo di chiedersi: chi sono? Cosa penso veramente? Tutto serve a distrarre, anche la musica, a tenere la gente preoccupata perché non pensi. Ecco, è il contrario di quello che voglio fare io”.
La cosa che più colpisce nei testi è l’amarezza con cui Morrison osserva la crisi finanziaria ed economica globale. In diverse canzoni il senso di indignazione per il materialismo e l’avidità che hanno avvelenato la società è palpabile e questo fin dal primo brano. Un Morrison indignato quindi ma musicalmente brillante.
Nel “No Plan B” è racchiuso il suo “senso” di suonare e fare musica, proprio per questo, nonostante la miriade di dischi pubblicati e l’età che avanza, “The Man” non è mai banale, potrà non piacere, potrà non suscitare emozioni come invece succede ai suoi fan, ma, non sarà mai scontato e superficiale. Questo è quanto basta per renderlo, nonostante la sua nota antipatia, un grande musicista.
#duemiladodici
Home – Identità Digitale
Sono su: Mastodon.uno - Pixelfed - Feddit