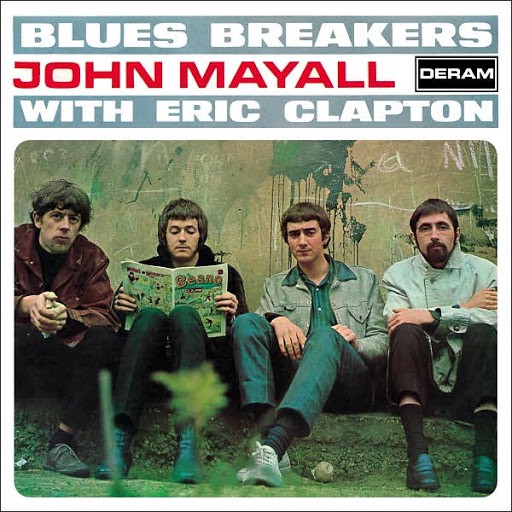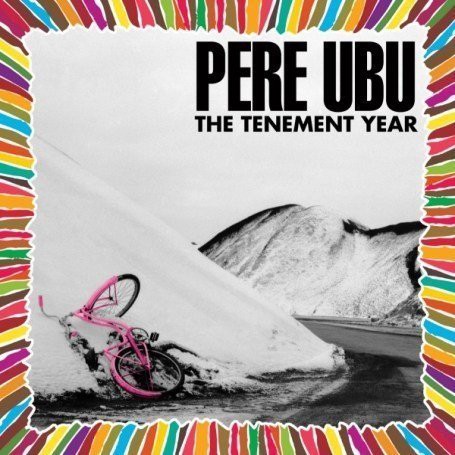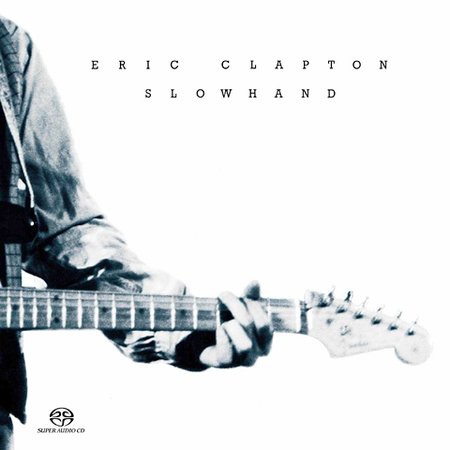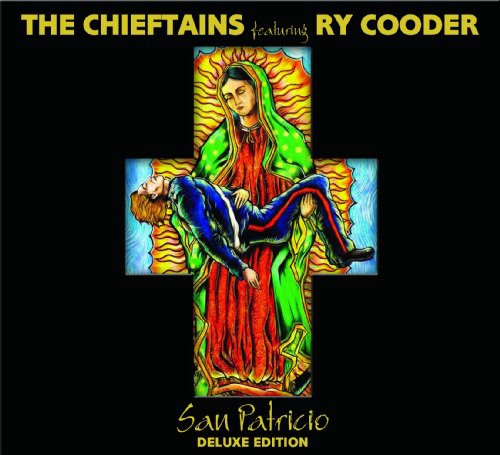Strange Angels fu fonte generosa di mille sorprese che, alcuni delusero ed altri fecero saltare di gioia. Ma cosa combinò la nostra per suscitare reazioni così contrastanti? Semplice: si è ingeniata a costruire dieci meravigliose canzoni (pop)olari. Chi ha storto il naso ascoltando “Language is a virus” farà meglio a tapparsi ora i canali auricolari: non più il gelido (splendido) esotismo tecnologico di “Mr Heartbreak”, ma un linguaggio sonoro diverso, più caldo, immediato, che parla in egual misura all’intelligenza e al cuore.
Nessun taglio netto con il passato: la Anderson di oggi (1989) è la stessa di sempre, solo discorre con maggior semplicità, con dolcezza e malinconia. Accarezza le tradizioni musicali del centro e del sud America, le culla con sguardo ironico (ma non cinico), le riveste d’eleganza europea e ce le porge cantando con grazie inaudita. Si Laurie canta e lo fa divinamente, abbandonandosi senza freni ad un’ondata melodica irresistibile.
La voce di Laurie Anderson passeggia tranquilla, si innalza ad acuti improvvisi, si trasforma con la stessa plastica duttilità di Kate Bush, rincorre suggestioni esplicitamente pop, si insinua tra cori gospel, tra ballate caraibiche con tanto di slide guitar, saltella tra le note squillanti dei fiati, rimbalza su morbidi e armonicissimi tappeti di tastiere, per poi riposare all’ombra del canto suadente della fisarmonica.
Un disco tranquillo e sereno, che rilega nell’angolo dissonanze e squilibri tonali, senza rinunciare ad essere acuto, lucido, penetrante, convincente. E’ una Laurie Anderson musicalmente terrena, priva di intellettualismi compiaciuti, un’artista che si impadronisce del pop, lo raffina, lo purifica ma non lo raffredda in glaciali schematismi.
Non si parli allora di commercialità; si dica piuttosto della genialità, della sincerità, del divertito candore con cui Laurie Anderson ha creato il suo ennesimo capolavoro.
#millenovecentoottantanove
Home – Identità Digitale
Sono su: Mastodon.uno - Pixelfed - Feddit