Bob Dylan — Oh Mercy (1989)

A parte la parentesi Traveling Wilburys, gli anni ottanta non sono stati i suoi anni migliori, un Dylan stanco e privo di creatività si è trascinato in tour e dischi non entusiasmanti e alcuni addirittura inutili. Proprio alla fine di questi, quasi come un’ancora si salvezza, a New Orleans, fra i profumi del voodoo e l’aria frizzante di Bourbon Street, Bob Dylan si decide a fare finalmente il Bob Dylan. In studio, con l’umidità che si aggrappa alle finestre, con pochi musicisti ma di cuore, incide il suo ventiseiesimo disco e le canzoni sono quelle di una volta.
Il gioco-forza si chiama Daniel Lanois, un giovane e grande produttore che, grazie alla sua maestria, riesce ad dare il suo imprinting con notevole personalità e pregevole fattura.
Oh Mercy diventa così un album attualissimo e allo stesso modo un disco senza tempo. Anche se non tutto il disco “naviga” in acque limpidissime, nel complesso, grazie ad alcune grandi canzoni; The Man In The Long Black Coat, Political World, Everything Is Broken e la bellissima Most Of The Time riescono a colpire emotivamente, in maniera profonda.
Non eravamo più abituati a questi canzoni, il Dylan ci aveva fatto assopire nelle sue ultime opere, ora invece, la bella voce, le sonorità delicate e spigolose, intense e rarefatte, fanno di questo Oh Mercy un disco completo, piacevole e per niente banale, una rinascita musicale dopo anni di stasi.
Avremmo tutto il tempo di ascoltarlo e di farlo nostro questo album, ci vorranno infatti, ancora altri otto anni prima che il nostro Dylan sforni un’altro ottimo disco, si chiamerà “Time Out Of Time”, sarà il 1997 è il produttore si chiamerà ancora una volta, guarda caso, Daniel Lanois.
Home – Identità Digitale Sono su: Mastodon.uno - Pixelfed - Feddit


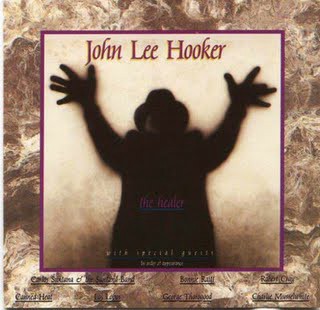


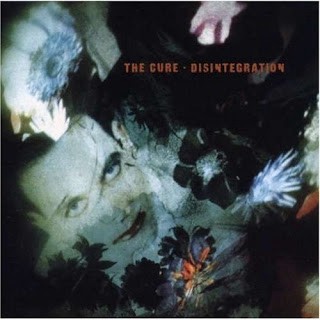

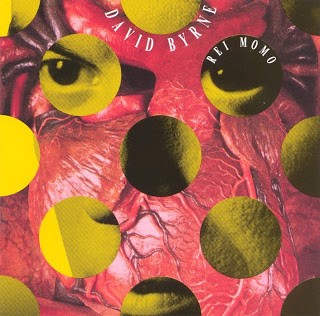 Effervescente, vivace, gioiosa è l’aria che ci fa respirare il sound, le note di questo Rei Momo.
Ancora una volta il musicista scozzese tira fuori dal suo cappello a cilindro la sua grande creatività.
Effervescente, vivace, gioiosa è l’aria che ci fa respirare il sound, le note di questo Rei Momo.
Ancora una volta il musicista scozzese tira fuori dal suo cappello a cilindro la sua grande creatività.