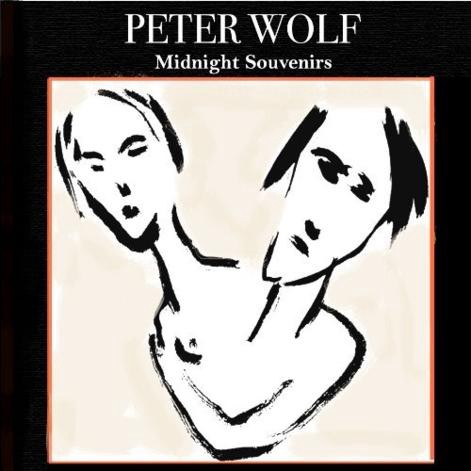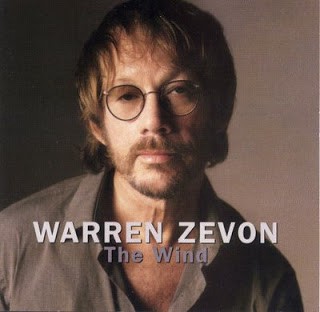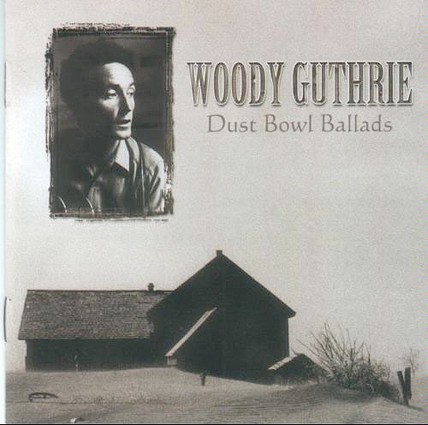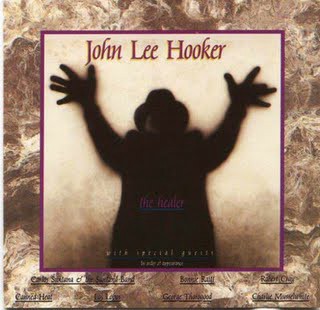E’ noto che Peter Gabriel sia piuttosto parco nella produzione musicale, infatti l’ultima sua incisione risale a otto anni fa. Dopo quattro album intitolati con i numeri: 1, 2, 3 e 4 e altri tre con le sillabe: So, Us e Up, questo è il primo disco che ha un nome più comune: Scratch My Back che, non a caso, è un album di cover, quindi canzoni di altri musicisti. Gli stessi musicisti sono stati chiamati poi in causa per contraccambiare “il progetto” incidendo delle canzoni sue.
Un album di cover fatto da Gabriel è però cosa diversa. I dodici brani presenti nel disco vengono completamente stravolti e arrangiati in maniera quasi irriconoscibile; pianoforte e archi sono il comun denominatore.
Il disco che necessità di un ascolto non superficiale, fa però sentire subito la sua profondità. Ogni brano che Gabriel prende in considerazione viene sviscerato, scarnificato, pulito fino all’osso. Con attenzione ad ogni minimo particolare, ogni canzone viene rivisitata, estrapolata dalla sua originale collocazione e portata in alti emisferi.
Passiamo al contenuto.
Le dodici canzoni del disco fanno parte alcune del passato ed altre di un recente appena trascorso, ma tutte sembrano scorrere in un binario appena costruito appositamente per loro, come se facessero parte di un treno dove Gabriel guida la motrice e i vagoni sono le canzoni tutte legate tra loro ma ognuna diversa.
Il primo brano è Heroes di David Bowie, canzone che non ha bisogno di presentazione quant’è conosciuta. Gabriel, minimizzandola, riducendola al massimo, con l’uso degli archi e alla sua voce unica, la fa sua. Grande partenza che ci fa ben sperare. Anche The Boy in the Bubble di Paul Simon viene spogliata dal suo originale suono “africano” e prende delle somiglianze oniriche, altro grande brano. Mirrorball degli Elbow, band inglese, viene romanzata a ‘mo di colonna sonora. Il brano si mantiene collegato agli altri due “vagoni” e prosegue nel “binario” immaginario sopra descritto. Con Flume di Bon Iver, giovane cantautore statunitense, c’è un leggero assopimento, niente di grave, anzi, il livello musicale si mantiene sempre sopra la media. E’ con Listening Wind dei Talking Heads che Gabriel ci riporta di nuovo in corsa. Il brano è magico, l’atmosfera che si respira è unica. Grande canzone. Si passa alla sesta canzone del disco ed è sempre ottima musica, il brano di Lou Reed è The Power of the Heart ed è tra i top del disco. Nel brano riecheggia l’anima di Reed ma Gabriel se ne appropria volontariamente come una gemma da incastonare. My Body is a Cage degli Arcade Fire è forse tra i brani che preferisco. Gabriel regala la sua interpretazione con un occhio di riguardo per questo gruppo. Il brano è intriso di pathos e allo stesso tempo raggiunge punte di alta interpretazione musicale e vocale. The Book of love dei Magnetic Fields è il brano di punta del disco, quello che per così dire tira nelle radio. Il brano è indubbiamente bello e ben costruito, orecchiabile al punto giusto senza guastare i padiglioni auricolari. Le prossime due canzoni: I think it’s goig to rain today di Randy Newman e Après Moi di Regina Spektor (bello il suo ultimo disco: Far, del 2009) rallentano un po’ la corsa di questo ipotetico treno, non drasticamente però. I due brani vengono “introspettati” da Gabriel, vengono portate alla luce quelle emozioni tenute nascoste quasi per pudore dai due originali autori. Siamo alla fine con le ultime due canzoni: Philadelphia di Neil Young e Street Spirit dei Radiohead. Sono forse i due brani più difficili dell’intero disco e come tali vanno ascoltati diverse volte per scoprirne le varie sfumature. Rivoltati fino a farne uscire le sonorità tipicamente “Gabrielliane”, in queste due canzoni più che nelle altre dieci, Gabriel ci mette tanto impegno da renderle uniche e splendide, quanto lo sanno fare i musicisti originali.
#duemiladieci
Home – Identità Digitale
Sono su: Mastodon.uno - Pixelfed - Feddit