Mi sono rotto le scatole di personalismi, narcisismi, ironie e autoironie assortite!
Oggi scriverò seriamente, nel tono professionale di un professorone stipendiato!
Introduzione
Ogni teoria economica si può suddividere in varie sottoteorie: teoria dei beni, teoria del valore, teoria dello scambio, teoria del prezzo, teoria della moneta.
A sua volta, ogni sottoteoria si può suddividere in varie sottocategorie, o casi particolari. E' il caso di questo post che analizza la teoria del “bene videogioco”.
I beni in generale
I beni sono strumenti atti a soddisfare un bisogno. Per tale motivo, chiedersi cosa sia un bene implica il definire quali siano i bisogni che soddisfa. Qualora si scopra accidentalmente che il nostro oggetto di osservazione non soddisfi alcun bisogno, allora non si può più parlare di bene.
Come si può perciò intuire, la qualifica di bene è una questione molto soggettiva e ciò che è un bene per alcuni può non esserlo per altri.
Un altra caratteristica interessante dei beni è il fatto che attribuiamo loro un valore e che siamo disposti a pagare un prezzo per acquisirli. Questo, com'è evidente, vale anche per i videogiochi.
Talune teorie economiche fanno risultare tale valore come sommatoria del lavoro e dei beni secondari (o materie prime) impiegati per costruirli o crearli. Queste teorie, nate durante la crescita e lo sviluppo una società industriale ormai alle spalle, hanno lasciato il posto anche in ambito accademico a impianti teorici che ragionano più sull'utilità per il fruitore o consumatore che sul lavoro incorporato nella produzione.
Il presente saggio si basa su quest'ultima impostazione giacché è evidente, ad avviso di chi scrive, che i beni abbiano valore solo in virtù della percezione e delle aspettative che hanno coloro che ad essi si rivolgono per soddisfare i propri bisogni.
Fatte tali doverose premesse, vediamo quindi quali bisogni vengono soddisfatti dai videogiochi.
Possiamo indicarne essenzialmente tre: il bisogno di divertimento, il bisogno di evasione, il bisogno di identità.
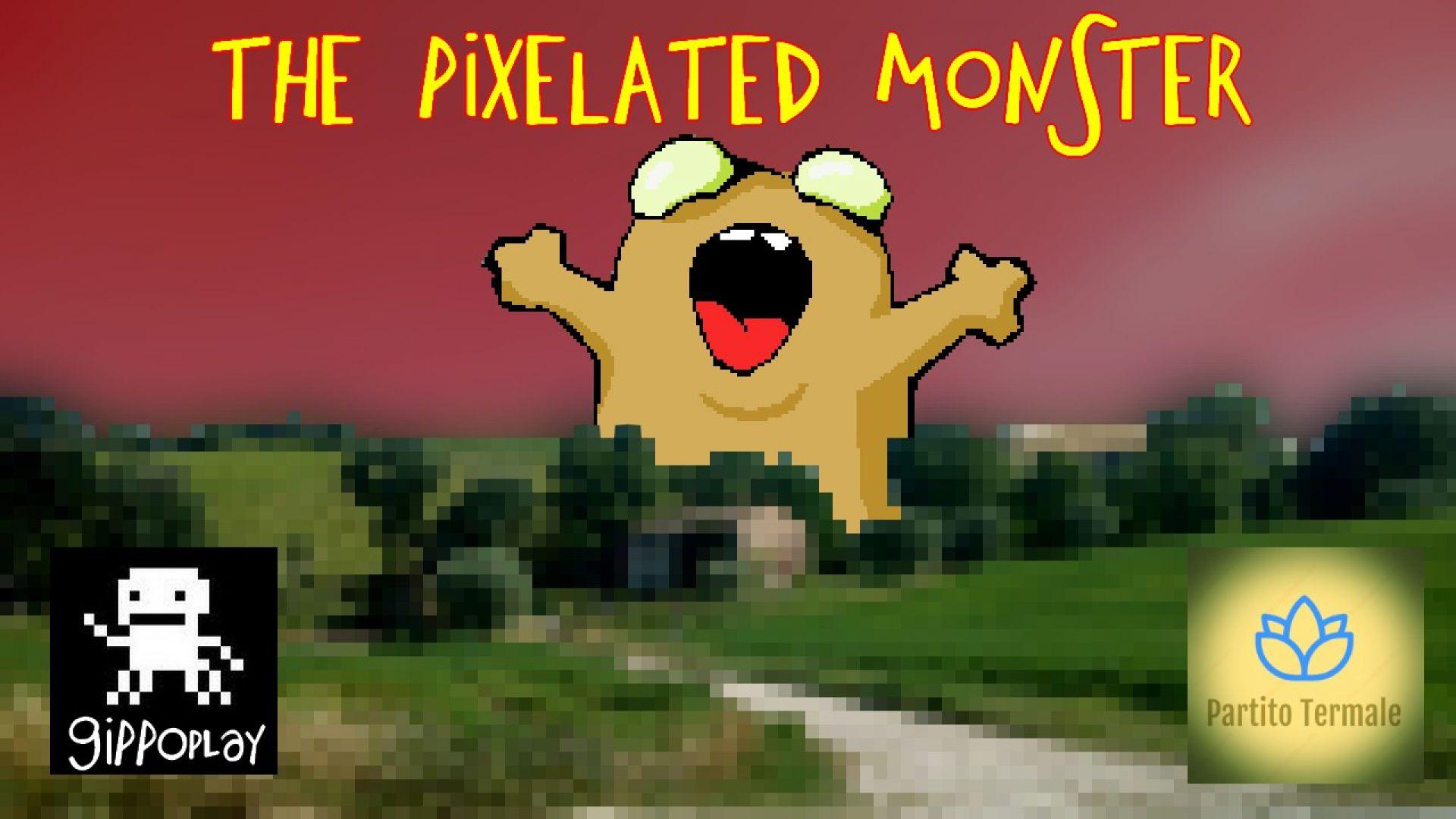
Il bisogno di divertimento
I videogiochi divertono, sono piacevoli, danno sensazioni positive. L'occhio è attratto ineluttabilmente verso le lucine in movimento sul monitor e il cervello segue con supino e languido senso di abbandono le dinamiche preconfezionate sullo schermo.
In questo ambito, il videogioco è una sorta di carezza al nostro intelletto, alla nostra curiosità, alla nostra voglia di sognare a occhi aperti. Se vogliamo, è un sogno interattivo a buon mercato. In una parola: diverte. Il bisogno principale di un videogioco, probabilmente quello per cui è nato, è proprio divertire con un senso di meraviglia.
Successivamente il senso di meraviglia si perde col susseguirsi delle incarnazioni videoludiche nelle loro infinite declinazioni, con l'evoluzione della grafica verso i limiti fisici, con la stabilizzazione e fossilizzazione dei generi. Però il divertimento non finisce con la fine del senso di meraviglia. E allora a supportarlo ci pensano il senso della sfida e del ritmo.
Il bisogno di evasione
Il videogioco crea esperienze altrimenti irrealizzabili per la maggior parte di noi, come guidare aeroplani e bombardare una regione del Medio Oriente. Oppure rubare auto e investire pedoni. Oppure interpretare supereroi e lanciare onde energetiche. In sintesi: ci fa evadere dalla prosaica realtà di tutti i giorni.
In verità anche divertire ha nella propria etimologia la parola latina “divertere” cioè cambiare strada e, in un'interpretazione un po' moraleggiante “uscire dalla retta via”.
Il videogioco realizza, sempre a buon mercato, l'opzione-fuga, quella che Henry Laborit ha descritto nel suo libro “Elogio della fuga”. La differenza tra divertimento ed evasione sta allora nella preponderanza dell'intimo bisogno di abbandonare la realtà, operazione questa fisiologica (cosa sono il sonno e i sogni se non l'insopprimibile esigenza di evitare dosi troppo pesanti di realtà?) ma che si presta a diventare, senza il giusto equilibrio, patologica.
A testimonianza della necessità di distinguere divertimento ed evasione c'è l'esperienza di tanti frequentatori del subredditdedicato allo “stopgaming”, una sorta di operazione di disintossicazione dal videogioco da parte di coloro per i quali quest'ultimo ha perso ogni connotazione divertente per essere sostanto il terreno preferenziale per la fuga sofferta e involontaria da se stessi e dalla società, in una dipendenza che ha perso la sua ragion d'essere iniziale.
Il bisogno di identità
Il videogioco, come ogni prodotto moderno, non sfugge all'ideologia attuale per cui non si vendono beni ma si vendono esperienze, modi di essere, tasselli identitari.In questo non è diverso da un profumo, da un'automobile, da uncibo biologico. Un primo tassello identiario agli albori della sua storia era quello sotteso all'essere nerd, geek, otaku. Successivamente, con il diventare sempre più mainstream, il videogioco ha finito col perdere parzialmente questo senso e da allora è diventato un e-sport, un sistema gerarchico a base di ladder, una tessera fedeltà a base di achievement, un negozio di abbigliamento virtuale a base di customizzazioni onerose.
Il videogioco dal punto di vista del consumatore è diventato un bene su cui investireal di là del prezzo sborsato per ottenerlo (che talvolta è pari a zero).
In quest'ottica, il divertimento continua ad esistere ma non per molto. Agli albori della sua storia un buon videogioco in termini di qualità/prezzo doveva garantire non meno di 40 ore di longevità. Al giorno d'oggi un videogioco deve essere potenzialmente per sempre attraverso il rilascio di aggiornamenti, espansioni, DLC, patch, modifiche di bilanciamento. Sintetizzando nuovamente: il videogioco è diventato un lavoro, un mezzo di espressione, un'arena competitiva.
In questo bisogno rientra anche l'importante fenomeno dell'appartenenza ad una community. Laddove vari anni fa la community aveva carattere esclusivamente amatoriale, oggi essa si avvale di professionisti e semi-professionisti qualificati: non solo moderatori selezionati tra utenti particolarmente responsabili e qualificati (in termini di “skill”) ma anche figure interne o comunque dipendenti a vario titolo dal team di sviluppo, quali social media manager e addetti alla comunicazione.
Conclusioni
E' interessante notare come una tale tematica sia stata affrontata da chi scrive anche dal punto di vista dello sviluppatore di videogiochi in questo post.
Si può intendere dunque il presente scritto come un aggiornamento maggiormente incentrato sui bisogni del videogiocatore, ovvero del consumatore finale, piuttosto che dello sviluppatore cioè il produttore. Ciò può fornire un interessante cambio di angolazione che mette a confronto le differenti percezioni di chi produce e chi fruisce, ponendo ancor più in evidenza che anche chi crea un videogioco, in fondo, soddisfa un suo personale bisogno ed è, in definitiva, un suo particolare consumatore.
Ok, academic mode off.
Gippo – Il mio Mastodon